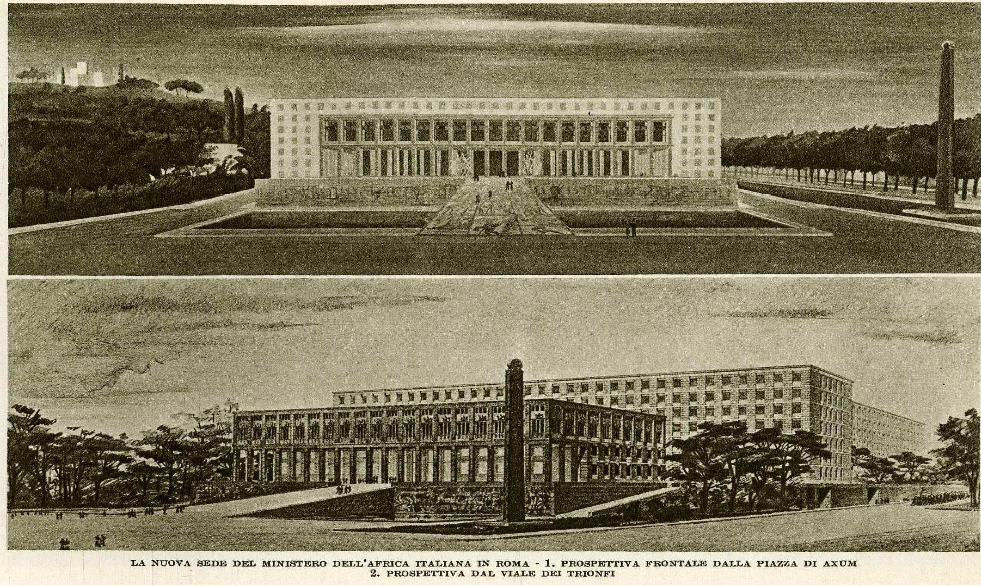Gian Carlo Stella, 10 giugno 2004
L’arco storico dell’esperienza coloniale dell’Italia in Africa ebbe inizio il 10 marzo 1882[1] per terminare, mano militare, alle ore 12,30 del 13 maggio 1943[2].
In quelle terre “oltremare” si avvicendarono, protagonisti e partecipi, centinaia di migliaia di italiani[3] che colà vi riversarono – aldilà di ogni retorica -, assieme alle armi ed agli strumenti di lavoro, desideri, sogni e speranze.
Su quei 61 anni, 2 mesi e 3 giorni molto è stato raccontato, a testimonianza di una stagione che vide due intere generazioni di italiani avvicendarsi in Eritrea, Somalia, Etiopia e Libia.
Tutto ciò si premette per delineare la vastità e l’importanza sociale, economica e politica che ebbe nella storia d’Italia il fenomeno coloniale, nato e sviluppato dagli stessi governi che si succedettero, e non imposto da “alcune minoranze chiassose”.
L’opposizione a questa politica (rammentiamo che Crispi fu contrario alla spedizione di Massaua del 1885), seppur minoritaria, comunque contribuì, se non ad annullare, almeno a frenare certe volontà espansionistiche. E questo aldilà delle grida di “viva Ras Alula” e “viva Menelik” che risuonarono pure nelle aule di Montecitorio, o dell’augurio di Filippo Turati che l’esercito italiano subisse in Africa una “batosta sintetica e risolutiva”[4].
L’opposizione alla politica espansionista coloniale prese vigore specialmente per virtù dei disastri sui campi di battaglia (Dogali[5], Amba Alagi e Adua, che produsse più morti di tutte le guerre del Risorgimento), per acuirsi alla vigilia dell’impresa di Tripoli dove lo stesso Mussolini (futuro fondatore di un Impero) conobbe la galera per atti di sabotaggio relativi alla sua protesta antitripolina, condotta assieme a Pietro Nenni. Il Ministro che subentrò a Crispi, benché avesse un programma di raccoglimento, non alienò i territori africani dell’Italia, come nessun appunto è mai stato mosso da chicchessia al feroce colonialista ed espansionista Menelik II.
Per la guerra contro l’Abissinia del 1935-36 il clima nazionale fu tanto euforico da produrre negli italiani un effetto straordinario, tanto che esuli antifascisti tornarono in Italia e partirono volontari, come pure mutilati, invalidi e studenti. Benedetto Croce e Luigi Albertini donarono, alla “Patria in armi e soffocata dalle inique sanzioni”, le loro medagliette d’oro da parlamentari. Pure la comunità ebraica di Roma volle partecipare alla conquista fascista, alienando oggetti d’oro della Sinagoga principale. Combatterono a fianco dei soldati anche ministri, deputati, personaggi della casa regnante e gli stessi figli di Mussolini. Fu un avvenimento epocale di entusiasmo e determinazione mai registrato nella storia d’Italia.
Ma da quell’epoca ad oggi le scale dei valori si sono alterate, nuove morali si sono affacciate o si sono fatte imporre. Più che altro, in quest’ultimo trentennio, si è cercato di identificare con il termine “colonialismo” una manifestazione di prevaricazione d’esportazione, imperialista, senza scrupoli, sebbene nel 1948, quando si discuteva sul ritorno dell’Italia in Africa, Palmiro Togliatti ebbe a scrivere: “Il governo inglese, se proprio vuol dimostrarsi nostro amico, perché invece di cominciare da Trieste, non comincia col dichiarare di essere d’accordo che rimangano all’Italia le sue vecchie colonie?[6].
Tutto ciò lo si sottolinea non per intento polemico, ma per ristabilire alcuni punti fermi dai quali non si può transigere comunque la si pensi.
Oggi, di quella particolare esperienza, resta solo quel poco che ha potuto destare nell’anima e creare con la materia; quasi nulla rispetto all’attività complessiva dell’Italia in Africa, ed in ogni caso, a seconda dei proponenti, sempre nei termini elogiativi o dispregiativi. Fenomeno, anche questo, esclusivamente italiano.
———————–
[1] Passaggio ufficiale del possedimento di Assab al Governo Italiano.
[2] Con una appendice somala di 10 anni, dal 1950 alle 30 giugno 1960, relativo al periodo di amministrazione fiduciaria.
[3] Complessivamente hanno calcolato 500.000 gli italiani, militari compresi, che si avvicendarono in Africa Orientale Italiana dal 1935 al 1941; circa 200.000 in Libia.
[4] Cfr.: “Critica Sociale”, 16 gennaio 1896.
[5] Giosue Carducci, prima di convertirsi alla monarchia, si rifiutò di celebrare quei caduti, “vittime di una spedizione inconsulta … [andati in Africa a fare] ciò che i Croati avevano fatto nel Risorgimento in Italia”, mentre Gabriele d’Annunzio, sempre riferendosi ai caduti di Dogali, li descrisse “quattrocento bruti morti brutalmente”.
[6] Cfr.: “L’Unità”, 26 marzo 1948.