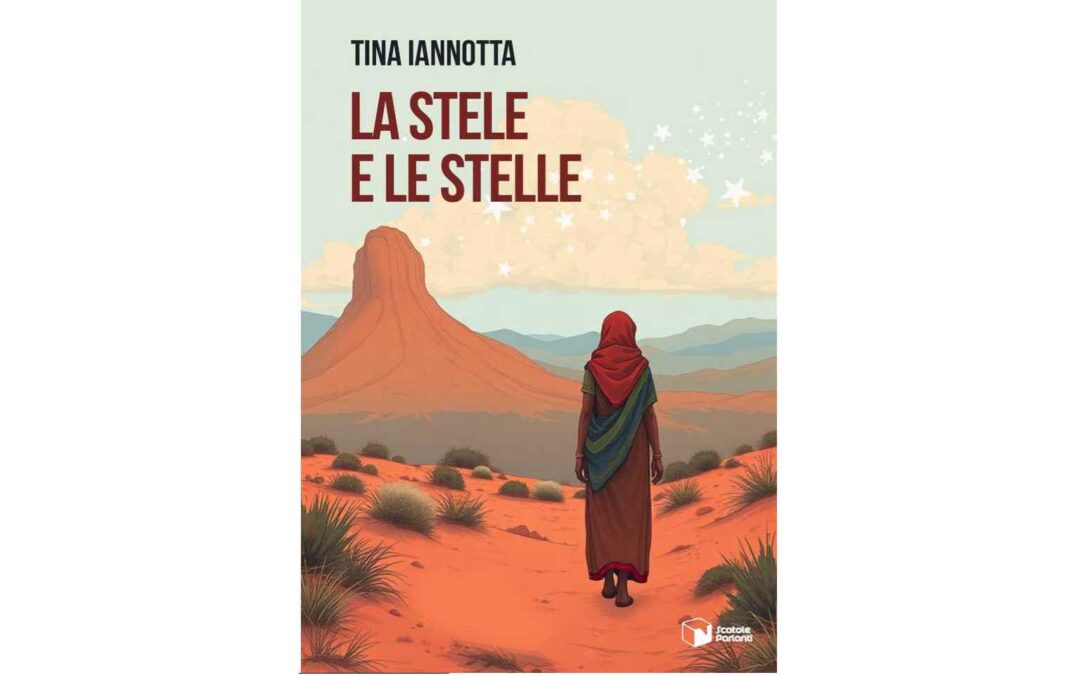Gian Carlo Stella, 20 aprile 2025
La lettura del volume ci porta in un territorio lontano, dove decine di migliaia di italiani di due generazioni riposero le speranze per una vita migliore. Per loro fu davvero la “terra promessa”.
Quel Paese è l’Eritrea, sulle sponde del Mar Rosso, nata ufficialmente come colonia nel 1890.
Venne creata dagli italiani, che vi costruirono città, strade, ponti, ferrovia, teleferica, acquedotti, fabbriche, aziende agricole, erigendo teatri, luoghi sportivi, chiese, moschee, sinagoghe, ecc. Decine di migliaia di nazionali qui nacquero, vissero, lavorarono e morirono, mantenendo la loro identità.
Asmara, come aspetto architettonico, era una città italiana, ed i nazionali non ebbero atteggiamenti diversi da quelli che avrebbero ostentato in patria.
Quando questa stagione finì, rimase per chi ci visse solo il ricordo di quella terra e qualche ninnolo esotico serrato nella valigia e poi esposto nel mobile buono di casa.
Orfani di un sogno naufragato, nella pelle e nella mente avevano però assorbito un qualcosa di non ben definito che si avvertiva conoscendoli o stando a loro vicini. Sembravano avvolti da una specie di alone e si riconoscevano subito.
Del loro vissuto, di quella stagione “coloniale” e “post-coloniale”, oggi non rimane che qualche ricordo in poche decine di libri di memorie; forse non arrivano a 20, e probabilmente nemmeno a 5 quelle scritte da donne.
L’opportunità di conoscere nel vivo la vita degli italiani in Eritrea, cosa facevano, come lavoravano, il modo di porsi, la morale dell’epoca, la loro quotidianità e spesso anche la loro intimità, il modo di vivere e di rapportarsi con gli altri, le loro speranze, gli auspici, i desideri, le delusioni, i pettegolezzi, il ricordo dell’Italia, i rapporti con gli autoctoni, sono qui raccontati in maniera spontanea, efficace e coinvolgente.
Non è un racconto rabberciato alla meglio attingendo da varie testimonianze; nella lettura si cammina per le strade di Asmara, si entra nelle case, nei negozi e nei locali; si citano personaggi allora noti, si partecipa ai vari avvenimenti mondani ed anche drammatici che la città ha conosciuto. Sono personaggi concreti e reali a contorno di una storia immaginata comunque molto verosimile. Un libro utile nella sua trascinante lettura, importante per il vuoto storico che colma.
—– °°°°° —–
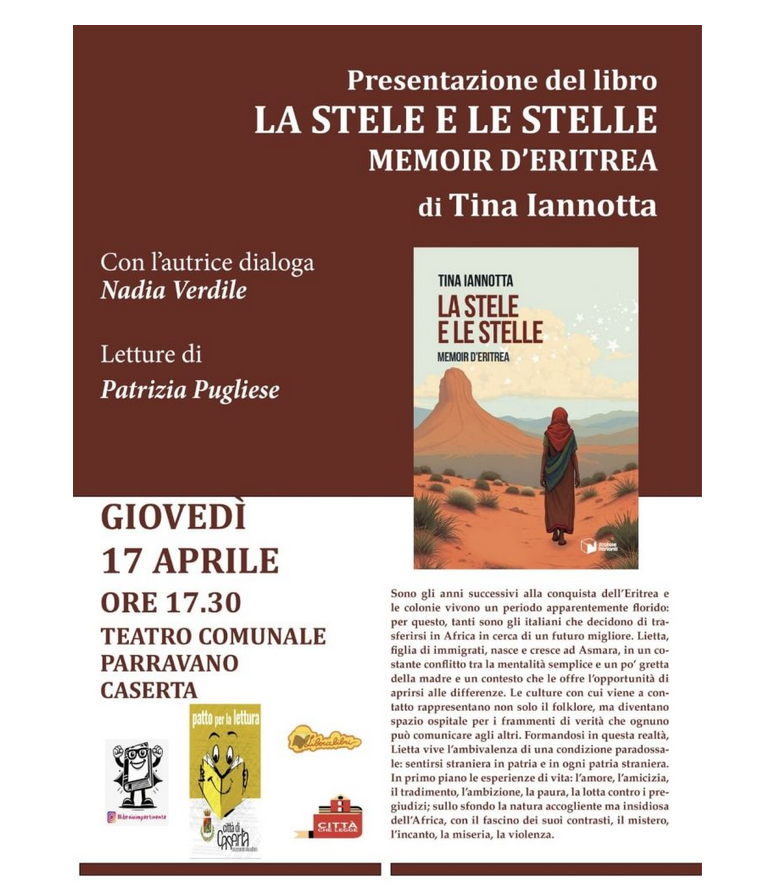

Da: by Michele Schioppa da GiornaleNews (https://giornalenews.it/oggi-le-stele-e-le-stelle-di-tina-iannotta/)–
————–° —————
La presentazione a Roma del volume
L’evento culturale è stato segnalato anche dal “TG Campania” ed è programmata, per mercoledì 29 ottobre anche una diretta Streaming sulla Pagina Facebook della FIAP,
Qui sotto è riprodotto il testo dell’appuntamento che ha veduto, oltre la partecipazione dell’Autrice salutata dalla Vicepresidente della FIAP Bianca Cimiotta Lami, gli interventi della storica Sonia Marzetti e di Sonia Gallico, autrice di pubblicazioni sulla Tunisia.
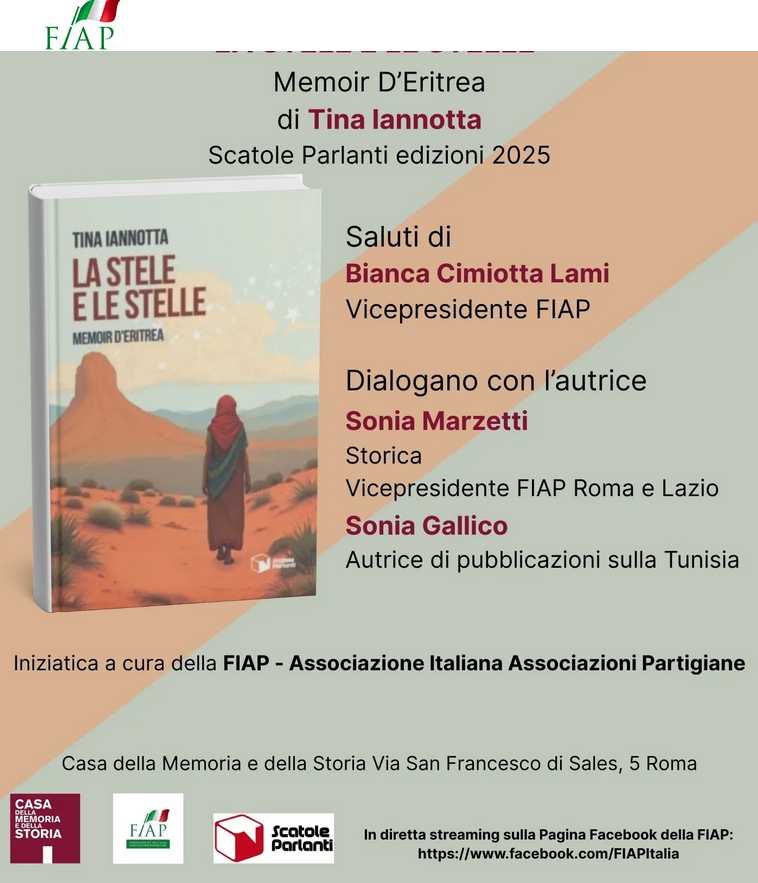
Tina Iannotta, autrice e testimone di una generazione di italiani nati e cresciuti in Africa, si definisce con lucida consapevolezza «figlia del fascismo d’Africa». Tale autodefinizione racchiude una duplice appartenenza: da un lato il riconoscimento di un’eredità storica — quella della presenza coloniale italiana — dall’altro la volontà di distanziarsene criticamente, di reinterpretarla alla luce di una memoria personale e familiare. Nelle sue parole si riflette la coscienza di appartenere a una stirpe “breve”, quella dei coloni italiani, una comunità sospesa tra il mito civilizzatore e il silenzio dell’oblio postbellico. «Quando il fascismo è caduto — racconta — ci siamo trovati come l’asino in mezzo ai suoni». La metafora esprime efficacemente lo smarrimento di una generazione privata di riferimenti, costretta a ridefinire la propria identità in un contesto nazionale che non riconosceva più il loro passato.
La caduta del regime non rappresentò soltanto la fine di un sistema politico, ma la dissoluzione di un immaginario collettivo e di una geografia affettiva. L’Africa, per questi italiani, era stata insieme patria e promessa, spazio di proiezione e di vita quotidiana. Il ritorno forzato in Italia segnò dunque una frattura radicale: non solo la perdita di una casa, ma la cancellazione di un’intera esperienza storica. «Siamo stati dimenticati due volte», afferma Iannotta: prima dalla storia ufficiale, poi dalla memoria pubblica. La sua voce restituisce la percezione di un’identità liminale, né più africana né pienamente italiana, relegata ai margini del discorso nazionale.
Nel racconto di Iannotta emerge una forte consapevolezza della rimozione della memoria coloniale italiana. La sua insistenza nel ripetere che la storia d’Africa fu “coperta, coperta, coperta” evidenzia la difficoltà del dopoguerra nel confrontarsi con la violenza del passato coloniale e con le sue eredità morali. La riscoperta di quella memoria — afferma — è legata al lavoro pionieristico di Angelo Del Boca, che con la sua ricerca ha scardinato la narrazione autoassolutoria costruita nel dopoguerra e incarnata, sul piano mediatico, da figure come Indro Montanelli, simbolo di un colonialismo “mite” e paternalista. La lettura di Del Boca, ma anche l’ascolto delle voci postcoloniali africane, rappresentano per Iannotta la chiave di un nuovo sguardo, più complesso e autocritico. In particolare, cita autrici come Maaza Mengiste, capaci di “ribaltare il punto di vista” e di restituire voce ai soggetti subalterni della storia.
Il rimpatrio del 1974, in seguito alla rivoluzione eritrea, segna per Iannotta il momento traumatico per eccellenza. La decisione di lasciare Asmara, la vendita forzata dei beni, il rifiuto di abbandonare il proprio cane pur di non imbarcarsi sui voli militari, sono episodi che condensano l’intensità emotiva del distacco e la tensione tra dignità e perdita. Il ritorno in Italia fu per lei «uno shock», non solo materiale ma antropologico: dopo anni trascorsi in una società “aperta, solare e comunitaria”, si ritrovò in un paese “freddo e chiuso”, dove la sua esperienza africana era oggetto di imbarazzo o rimozione. «La nostra memoria — racconta — esisteva solo dentro di noi. Nessuno voleva sentirne parlare.»
In questa testimonianza si riflette quella condizione di sradicamento e marginalità che accomuna molti rimpatriati dall’Africa Orientale: una memoria diasporica priva di riconoscimento, sospesa tra nostalgia e negazione, analoga a quella che Triulzi ha definito “memoria d’ombra”.
Nel suo romanzo del 1975, Iannotta trasfigura l’esperienza personale in una narrazione lirica e allegorica. La frase «Piazza dei Cinquecento colma di storia coloniale era la testimonianza del suo mondo che era ancora in guerra» diviene emblematica di una scrittura che si fa strumento di elaborazione del lutto e, insieme, di denuncia. Lo spazio urbano — luogo di arrivi e partenze — diventa metafora della dislocazione identitaria: la piazza romana come crocevia tra due mondi, simbolo di una diaspora invisibile. La letteratura, in questo senso, agisce come dispositivo di memoria: non solo rievoca, ma interroga, rielabora, trasforma il passato in oggetto di riflessione critica.
Nell’elaborazione di Iannotta, la “terra di mezzo” assume un valore paradigmatico: rappresenta lo spazio simbolico e concreto in cui si intrecciano identità multiple, appartenenze ibride e sentimenti contraddittori. Non è un semplice “tra” geografico, ma una categoria esistenziale e politica. In essa si situano le vite dei coloni e dei loro discendenti, ma anche i percorsi dei soggetti africani e meticci che hanno abitato l’esperienza coloniale. L’Africa coloniale e postcoloniale diventa così il luogo della memoria incrociata, dell’incontro e dello smarrimento.
Accanto alla dimensione del trauma, nella testimonianza di Iannotta emerge anche una memoria positiva, legata alla quotidianità della convivenza interetnica. Ricorda una società multiculturale e cosmopolita, dove italiani, ebrei, indiani, abissini e francesi vivevano in uno spazio comune, condividendo feste, riti e celebrazioni. «Non avevamo problemi — dice — festeggiavamo tutto: il Ramadan, lo Yom Kippur, il Natale copto, il Meskel. Era una società etnica, ma accogliente.» Questo ricordo, pur venato di idealizzazione, introduce una dimensione contro-discorsiva rispetto alla retorica della segregazione coloniale, e rimanda a un vissuto che precede la costruzione ideologica della razza.
Il suo racconto testimonia così una tensione costante tra nostalgia e critica. Se da un lato rievoca la perduta armonia di un mondo “meticcio”, dall’altro denuncia le responsabilità storiche e la rimozione della violenza coloniale. La memoria, per Iannotta, non è mai pura idealizzazione: è piuttosto una forma di resistenza all’oblio, un modo per affermare la dignità di una generazione rimossa dalla narrazione nazionale.
La voce di Iannotta si inserisce pienamente nella genealogia di quella che si può definire “memoria di confine”: una memoria che nasce dall’esperienza del margine e della dislocazione, e che si confronta con la difficoltà di trasmettere il passato in assenza di riconoscimento collettivo. Essa dialoga con le riflessioni teoriche di Lombardi-Diop e Romeo, secondo cui la memoria coloniale italiana si costruisce oggi attraverso narrazioni diasporiche, intime e frammentarie, capaci di riaprire le faglie del rimosso.
In questo senso, la testimonianza e l’opera di Tina Iannotta non si limitano a raccontare il trauma della perdita, ma offrono una chiave interpretativa per comprendere la lunga durata della rimozione coloniale e la necessità di una sua rielaborazione critica. La sua “terra di mezzo” non è solo uno spazio geografico, ma un dispositivo di memoria che consente di pensare l’Italia postcoloniale come comunità in dialogo con le proprie ombre.
————————*———————-