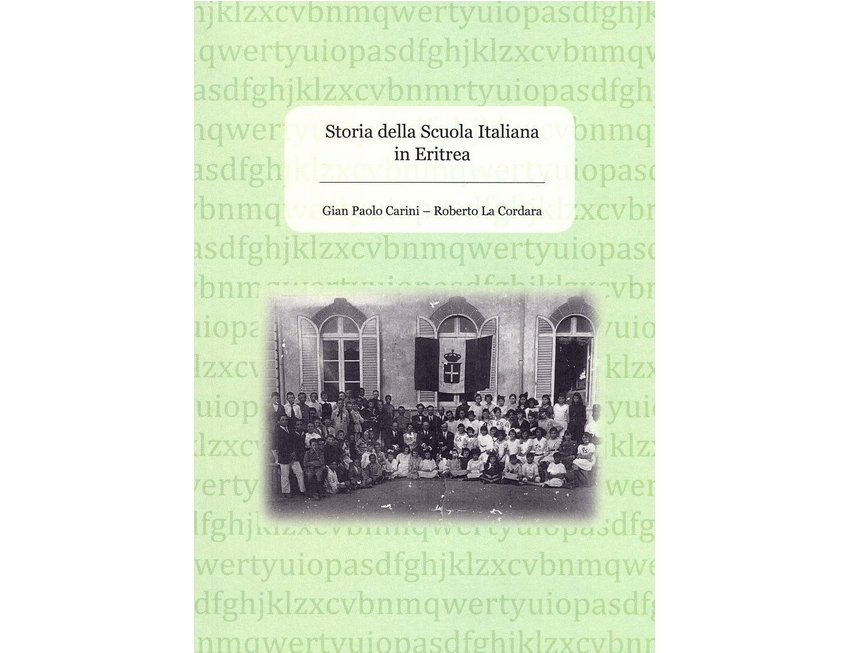| Gian Paolo Carini – Roberto La Cordara Storia della Scuola Italiana in Eritrea 2012 15 € AGGIORNAMENTO dicembre 2014: Il testo recensito è stato ultimamente ristampato a cura di G. Pozzi editore con il codice ISBN 9788896117477 ed alcune modifiche che riguardano: – una migliore qualità delle fotografie ed una ‘copertina’ diversa – alcune piccole varianti nel testo – una premessa del prof. M. Zaccaria, docente alla Università di Pavia. E’ possibile leggere la prefazione e le prime pagine del testo a questo link https://www.giorgiopozzieditore.it/collane/popoli-societa-e-culture/44-gian-paolo-carini-roberto-la-cordara-storia-della-scuola-italiana-in-eritrea.html https://www.giorgiopozzieditore.it/collane/popoli-societa-e-culture/44-gian-paolo-carini-roberto-la-cordara-storia-della-scuola-italiana-in-eritrea.htmlChi scrive ha potuto notare, alcuni anni fa, ad Asmara, una scena in Italia ormai dimenticata: bambini tra i sei e i dieci anni, con grembiulini neri per i maschietti e bianchi per le femmine, che si recavano a scuola, da soli, magari a gruppetti, ma senza la scorta di genitori apprensivi (d’altra parte il traffico ad Asmara non è quello delle nostre città), sorridenti (guardate invece i nostri bambini!) e che, miracolo dei miracoli!, anziché traccheggiare ed indugiare sui marciapiedi per rimandare l’ingresso nelle odiate aule, si precipitavano correndo e ridendo verso l’ ingresso della Scuola Elementare “M. Buonarroti”, temendo di arrivare tardi al suono della campanella. Scena ormai talmente inusuale dalle nostre parti che mi è rimasta fissata nella memoria. La presenza delle scuole italiane in Asmara è talmente radicata nella società asmarina (basta fare due chiacchiere con qualche asmarino per accorgersene) che la paventata chiusura, nel 2012, di tali storiche istituzioni per un problema burocratico-diplomatico aveva creato non poco sconcerto e scalpore. Pochi mesi prima di tale ipotesi, fortunatamente scongiurata, era uscito, nel maggio 2012, un testo che traccia, in maniera approfondita e completa, la storia delle scuole italiane in Eritrea. Il volume è arricchito da numerose fotografie d’epoca e supportato da abbondanza di dati, tabelle, programmi, dettagli e particolari su ogni istituto, sia in Asmara che nel resto dell’Eritrea, nonché sui circoli studenteschi. Il problema di creare istituzioni scolastiche, dapprima per gli indigeni, poi per i figli dei nostri residenti, si pose fin dai primi momenti dell’insediamento italiano. La scuola veniva vista come ottimo mezzo per la diffusione della lingua e quindi della cultura italiana, e infatti già in tutto il Mediterraneo, dove si trovavano comunità italiane, il Regno d’ Italia, appena nato, aveva fondato scuole aperte anche ai locali, ad Alessandria d’ Egitto, a Tunisi, a Costantinopoli, tanto che nel 1881 si potevano contare già 87 scuole italiane nel mondo, con lo scopo sia di diffondere la cultura che di mantenere il senso di identità nazionale tra gli emigrati. In Eritrea, prima della fondazione della colonia, erano già presenti scuole religiose, copte o coraniche, a cui si aggiunsero poi le scuole missionarie di vari ordini religiosi. Con una certa lungimiranza ed apertura mentale, fin dall’occupazione di Massaua vennero create scuole per gli indigeni, sia cristiani che mussulmani, sia maschi che femmine; erano organizzate e gestite da religiosi, ma con ampio appoggio governativo. Leggendaria, a questo proposito, la figura del comboniano padre Luigi Bonomi. È con Ferdinando Martini che, nel 1902, nasce ad Asmara la prima scuola elementare interamente governativa; si apriranno poi altre sedi in varie località. Erano, e non è male sottolinearlo, laiche e miste, con insegnamento obbligatorio delle lingue locali. Genitori ed istituzioni, pare di notare, erano molto partecipi dell’importanza degli studi, come si rileva dalle loro puntuali sollecitazioni e richieste. Particolari le scuole per ascari: ogni battaglione aveva la propria, e ne esistevano anche per i figli degli ascari. Non tutti, in Italia, approvavano le spese per l’inaugurazione di scuole in colonia, quando obiettivamente se ne avvertiva la carenza sul territorio nazionale; ci volle un altro governatore di polso, Salvago Raggi, perché il ciclo di studi post-elementari venisse completato con la creazione della Scuola d’ Arti e Mestieri e della Scuola bilingue arabo-italiana (a informarsi appena un po’ sull’ opera di gente come Ferdinando Martini o Giuseppe Salvago Raggi vien da ipotizzare, chissà perché, che la classe governativa e diplomatica dell’ epoca fosse più energica e capace di quella attuale…) Le Scuole d’ Arti e Mestieri si diffusero in tutto il territorio, nonostante una iniziale ostilità dei locali, che spesso guardavano con sospetto, se non con avversione, queste innovazioni. D’altra parte, è anche comprensibile lo scarso interesse da parte degli indigeni ad approfondire l’istruzione dopo le elementari, data la facilità (che tempi!) di trovare un impiego statale o privato, tanto più che appena assunti frequentavano un tirocinio remunerato (decisamente, roba d’altri tempi…) Una svolta ed ampliamento dell’offerta formativa arriva negli anni del fascismo, con la riforma Gentile del 1923, che ovviamente riguarda anche l’Eritrea. L’accentramento ed il controllo governativo di questi anni è in un certo senso un bene, perché garantisce la sopravvivenza di alcune scuole religiose e private che avrebbero corso il rischio di chiudere con la scomparsa del loro fondatore (come era il caso, per esempio, del già citato padre Bonomi). Dopo la parentesi della guerra italo-etiopica, che vede la chiusura momentanea di tutte le scuole, trasformate in ospedali militari, gli Istituti di istruzione superiore si ampliano e diversificano. Nascono in quegli anni il Liceo Ferdinando Martini e l’Istituto Tecnico Bottego, che saranno poi seguiti dall’Istituto Magistrale. Anche la parentesi dell’amministrazione britannica, nonostante tutto, viene messa a profitto: dato che la popolazione civile italiana venne concentrata in Eritrea, per impulso di medici e docenti giunti ad Asmara nacquero diversi corsi superiori ed universitari (di medicina e giurisprudenza) con regolari programmi parificati, seguiti poi da laurea in Italia (corsi che avevano anche l’indubbia utilità di sottrarre al servizio militare, in quanto studenti, parecchi giovani…). Il prestigio delle scuole italiane in Eritrea era ormai tale che, nonostante l’amministrazione britannica escludesse ormai l’italiano come lingua utilizzabile nei pubblici uffici, non vennero mai a mancare iscritti italiani, eritrei e di altre nazionalità. Da un istituto italiano, l’Istituto Universitario Santa Famiglia, nel 1963 si sviluppa l’Università di Asmara, che vide negli anni Settanta, all’epoca del Derg, seri abusi contro la libertà accademica, fino all’uccisione di un docente di economia, Petros Habtemikael. Nel 1977, il Derg chiuse tutte le scuole, tranne le elementari “Buonarroti” e la Media “Volta”. Gli edifici vennero requisiti (e mai più restituiti allo Stato Italiano, che ne era stato creatore e proprietario). Il testo sviluppa l’argomento fino a tempi recenti, quando il Progetto Sicomoro adatta i programmi alla realtà e ai bisogni locali, mantenendo però una solida preparazione culturale, che fa delle scuole italiane istituti di prestigio, particolarmente apprezzati dalla borghesia eritrea. Tuttora, il Liceo Marconi (nuova intestazione del Liceo Ferdinando Martini) diploma ogni anno 50/60 studenti, con ottimi livelli di competenze e conoscenze. Il volume, del costo di 15 €, si può richiedere alla libreria Ancora dei Padri Pavoniani di Monza (039/324745; libreria.monza@ancoralibri.it)      Asmara, ingresso del Liceo Marconi (foto dell’ A.) |