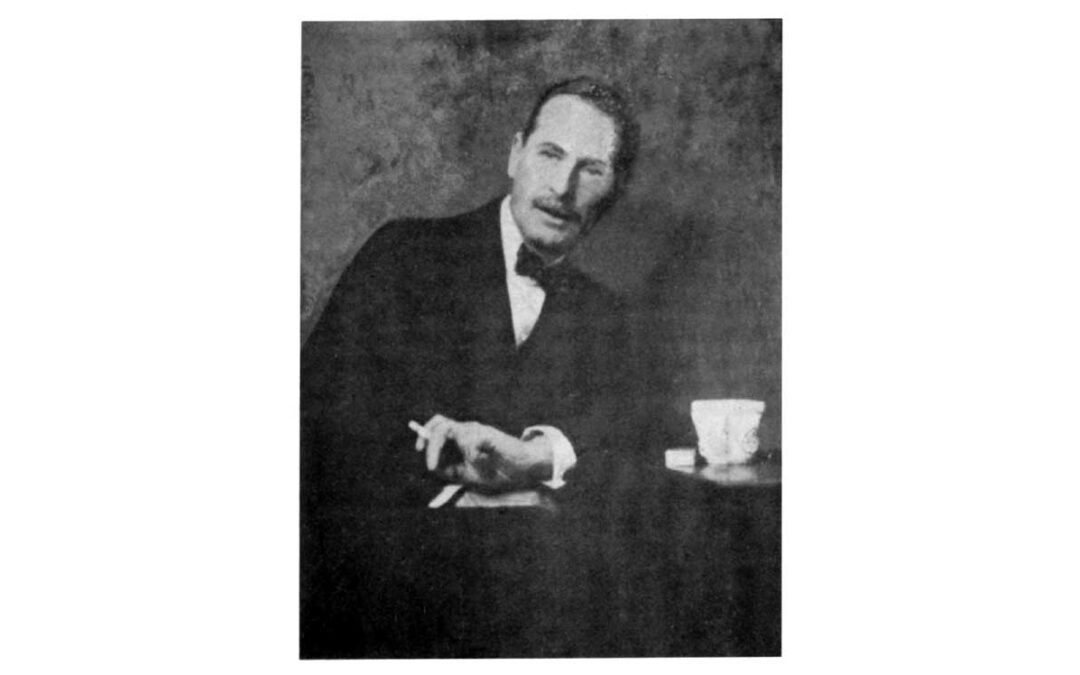| Manlio Bonati, ottobre 2004 |
| Sia i romanzi che i film ambientati nell’Ottocento ci hanno di norma presentato i giovani ufficiali come personaggi dediti ai piaceri della vita: cacce, gare ippiche, gioco d’azzardo e, naturalmente, donne. Il sottotenente di cavalleria dei Lancieri di Novara conte Giuseppe Colli di Felizzano, bello e distinto, non si discostava da questo archetipo. Era nato a Torino (alcuni autori specificano Saluzzo) il 9 settembre 1870, rampollo di una famiglia dalle antiche tradizioni militari. Il padre, generale Corrado, lo avviò alla carriera nel Collegio Militare di Milano. Nel 1889 uscì dalla Scuola Militare di Modena con il grado di sottotenente. Passata l’euforia dei primi anni, mise la testa a posto e si dedicò seriamente allo svolgimento delle proprie responsabilità. Fu per ristabilirsi da una malattia che decise di intraprendere un viaggio in Oriente. Visitò l’India e la Birmania, rimanendo affascinato da questi luoghi ed in particolare dalla vita coloniale. Tornato in patria, il Colli riuscì nel 1896 a farsi destinare nella nostra Colonia Eritrea al seguito del generale Baldissera. Qui si distinse nei combattimenti contro i dervisci, i seguaci sudanesi del movimento religioso mahdista, nei pressi di Cassala. Il Colli comandò uno dei primi gruppi di Meharisti, reparto di cammellieri indigeni. Inoltre, come scrisse il suo biografo, l’ambasciatore Giuliano Cora, “ebbe il delicato compito di proteggere le comunicazioni fra il lontano presidio di Cassala e quello di Agordat, minacciate da parte dei dervisci. In seguito alla sua azione ed alle informazioni fornite, il Generale Viganò fu posto in grado di riunire tempestivamente in Agordat un corpo di truppe che costrinse i dervisci a ripiegare precipitosamente mentre la loro retroguardia era molestata dalle forze mobili del conte Colli che molto opportunamente si era mantenuto in osservazione e in agguato fra i roccioni dei monti Elit”. Considerato dai suoi superiori come valido elemento adatto alla vita africana, fu nominato regio residente a Mogolo, dove viveva, unico bianco fra i suoi cammellieri, in un’umile casetta, costruita con materiali d’occasione. Successivamente lo trasferirono come residente a Bara Mogareb in Agordat, con la giurisdizione su tutto il territorio confinante ad ovest con il Sudan anglo-egiziano e a sud con l’indefinito confine con l’Abissinia. In quel periodo espletò vari compiti per il commissario civile Onorevole Ferdinando Martini, che scoprì nel giovane collaboratore l’attitudine all’attività diplomatica. Infatti gli diede il difficile incarico di delimitare la frontiera fra l’Eritrea e il Sudan assieme alla delegazione inglese diretta dal Talbot. Il 16 aprile 1901 la convenzione Talbot-Colli, con relativa carta geografica che delimitava i confini, era una realtà. Nel 1903, durante una discussione in Senato, il senatore Pippo Vigoni, che in gioventù si era dedicato alle esplorazioni, ammise che la convenzione anglo-italiana era un “perfetto documento diplomatico “. La carriera africana del Colli era ormai avviata. Il Martini lo fece destinare ad Addis Abeba in qualità di segretario della Regia Legazione, diretta dal maggiore Ciccodicola, per dedicarsi sempre allo spinoso problema delle modifiche dei confini tra l’Eritrea, il Sudan e l’Abissinia. Nel 1902 la legazione inglese, diretta da sir John Harrington, aveva firmato un trattato per la sistemazione della questione delle acque del Lago Tana e della frontiera etiopico-sudanese (ricordo che il Sudan era sotto l’influenza britannica). Colli doveva mettersi a confronto con colleghi stranieri capaci e potenti. Il Cora così chiarifica questo importante periodo della vita del Nostro: “il primo incarico diplomatico ricevuto dal Colli in Etiopia fu appunto connesso con l’attività britannica. Egli accompagnò in qualità di osservatore la missione Baird-Butter che nel novembre 1902 si recò nei Borana e Sidamo, sul Ganale e sul Sagan fino al lago Rodolfo per iniziare gli studi relativi alla delimitazione del confine tra l’Etiopia e il Kenya. Una missione assai curiosa, in fondo. Il Ciccodicola aveva ottenuto che il tenente Colli accompagnasse la missione Baird senza alcun incarico ufficiale, ma come osservatore per eventualmente tutelare che la futura linea di confine non interferisse con gli interessi italiani rappresentati dalle carovaniere per il commercio fra la Somalia e quelle regioni dell’Impero Etiopico, e raccogliere tutte le informazioni possibili specialmente sulla regione dei Borana. Anche il governo Etiopico, che aveva la sua missione, capitanata da un cagnasmacc Degafù, aveva acconsentito a che il Colli facesse parte della spedizione. Questa situazione, affatto insolita, dimostrava i buoni rapporti esistenti con la Legazione d’Italia. La spedizione durò per il Colli 8 mesi e fu una vera esperienza africana. La carovana percorse alcune fra le più belle ed altre fra le più dure regioni dell’Etiopia. Giam-Giam, Sidamo, Borana, Cambata, lago Margherita fra le prime ed il desolato bassopiano che segna l’attuale linea di frontiera fra Malka Mourra ed i laghi Stefania e Rodolfo”. La spedizione partì nei pressi di Addis Abeba l’8 novembre 1902. Vi erano cinque europei (Butter, Baird, Maud, Wekman, Colli), quattro indiani, centodiciotto somali, quarantuno abissini e più di centoventi animali tra cammelli da basto, cavalli, muli, asini. Le carovane erano due: quella inglese, più numerosa, e quella del capitano Colli, a cui si unirono due ufficiali abissini scelti per l’occasione dallo stesso Menelik. L’esploratore tenne un diario che poi gli servì per la relazione, intitolata Nei paesi Galla a sud dello Scioa, che venne stampata in due puntate nel 1905 nel Bollettino della Società Geografica Italiana di Roma. Il giovane ufficiale era pieno d’entusiasmo e di passione per l’Africa, consapevole di essere il primo italiano che procedeva sulle orme di Vittorio Bottego. Ma com’erano cambiati i luoghi descritti dal connazionale soltanto pochi anni prima! La conquista dei guerrieri abissini, gli Amhara, del 1896 aveva messo a ferro e a fuoco quei territori un tempo ricchi di fiorenti villaggi e rigogliose coltivazioni. I pochi indigeni rimasti scappavano appena la carovana era in vista: ritenevano fossero gli Amhara! Inoltre percorrendo la provincia di Sidamo, il Colli annotava che “l’avorio, che come tutte le province dell’impero è monopolio dell’imperatore e dei grandi capi, è qui ancora abbondante benché in continua ed inquietante diminuzione. Questo ricco prodotto, che se fosse regolamentato da leggi razionali e severamente applicate, rappresenterebbe ancora per l’Etiopia un cespite di prosperità e ricchezza, è invece il punto di mira a cui convengono tutte le ambizioni di ogni abissino, dall’imperatore che lo monopolizza all’ultimo dei soldati che lo cerca nei boschi, per soddisfare l’istintivo bisogno di gloria, colla fama di valoroso che viene attribuita all’uccisore di elefanti, e lo vende di nascosto”. L’osservatore Colli riuscì con successo a limitare le pretese territoriali inglesi, interessati ad una parte del territorio dei Borana, provincia importante per il commercio con la nostra colonia del Benadir. L’eventuale accoglimento delle richieste britanniche avrebbe significato la fine di Lugh, villaggio sul Giuba, come centro commerciale con la conseguente interruzione della via di comunicazione coi Borana. Il progetto inglese, che giocava sull’ignoranza abissina per le carte geografiche, fallì e la frontiera fu in seguito stabilita sulla linea dalla confluenza Daua-Ganale al lago Rodolfo. In pratica il Colli riuscì ad evitare che gli accordi tra l’Inghilterra e l’Etiopia non riuscissero di pregiudizio agli interessi italiani. Una lunga fermata della carovana alla confluenza dei fiumi Daua e Afelata, fece venire l’idea al Colli di seguire da solo il corso del Daua sino a quando si congiunge con il Ganale e visitare la stazione di Lugh. Il 22 gennaio 1903 si staccò dalla spedizione inglese e si mise in marcia. Appassionato cacciatore, prendeva di mira leoni, rinoceronti, elefanti. Ma proprio durante una battuta di caccia grossa avvenne un tragico incidente. Il 6 febbraio si trovava nel deserto di Banasa, a sud di Maddo, quando dopo tre ore di marcia una guida Gherri gli indicò un branco di elefanti al pascolo. Un enorme pachiderma si accorse dei cacciatori. Preso dalla furia, caricò i nuovi venuti. Il Colli si trovava a circa trenta metri dal gigantesco mammifero. Prese tranquillamente la mira e sparò. L’elefante fu solamente ferito, allora il cacciatore si volse verso l’ascaro abissino, che lo seguiva, per cambiare il fucile scarico. Il porta fucile invece di consegnare l’arma al Colli, preferì puntarla verso l’animale e, preso dal panico, fece fuoco praticamente senza mirare. Subito dopo, senza neppure curarsi di vedere l’esito della propria azione, l’ascaro si diede ad una fuga precipitosa. La pallottola prese in pieno il palmo della mano sinistra del Colli, arrecandogli una brutta ferita, dalla quale uscivano fiotti di sangue. Fortunatamente l’elefante non infierì contro gli uomini, preferendo condurre altrove il branco. Il Cora racconta che il ferito, lontano dal campo e senza medicinali, “non esitò a rimettersi ai sistemi indigeni per fermare l’emorragia ad opera di un vecchio somalo. Ed a piedi se ne tornò al campo”. Il caldo torrido e lo strapazzo della camminata gli fecero venire una febbre altissima. Gli ascari, temendo per la sua vita, decisero di chiedere aiuto agli altri europei, accampati lontano alcune giornate di marcia. Finalmente il dottore poté raggiungere il conte che, per timore della cancrena, si era fatto nuovamente medicare dal “vecchio somalo che gli stava estraendo dalla mano i pezzetti degli ossi maciullati”. Il dottore ammise che furono proprio queste primitive medicazioni che gli salvarono la vita. Il ferito fu poi trasportato al campo principale dove gli inglesi si prodigarono nelle cure. Il Colli si ristabilì, ma l’anulare e il mignolo della mano sinistra gli rimasero sempre piegati ed inservibili. Dopo un lungo riposo e dopo aver rinunciato a raggiungere Lugh, seguì di nuovo gli inglesi diretti al lago Rodolfo. Qui si commosse nel compiere il pellegrinaggio in memoria di Bottego, che aveva scoperto che l’Omo si getta nel lago. Invece in aprile, salutati gli amici europei, visitò i laghi Ciamò e Margherita. Infine riprese la via di Addis Abeba, dove vi giungeva il 14 maggio 1903. Terminava così la sua attività di esploratore ma, salvo l’interruzione di circa tre anni quando fu a Firenze come ufficiale d’ordinanza di S.A.R. il Conte di Torino, visse complessivamente nel Continente Nero per quasi trenta anni. Il conte Colli ritornò nel 1907 alla Legazione della capitale etiopica dopo essere stato nominato Incaricato d’Affari ad Addis Abeba, in sostituzione del maggiore Ciccodicola. Dovette subito rimboccarsi le maniche per risolvere un grave problema che poteva incrinare l’amicizia del suo governo con quello che l’ospitava. Il 15 dicembre a Bardale, nei pressi della non ben delineata frontiera tra la Somalia italiana e l’Etiopia, venivano assassinati per mano del Fitaurari Asfau i capitani Molinari e Bongiovanni con molti dei loro ascari. Il Ministro degli esteri Tittoni incaricò il Colli di presentare una formale protesta al Re dei Re. Nel documento si richiedeva anche la punizione dei colpevoli. Il diplomatico si adoperò tanto da riuscire a far imprigionare il Fitaurari Asfau e a farsi restituire i fucili tolti ai nostri morti. Questo incidente mise in luce un altro problema, quello della definitiva delimitazione della frontiera meridionale. Ancora una volta il Capitano Colli riuscì nell’impresa: il 16 maggio 1908 il Nostro e Menelik firmarono la Convenzione per la sistemazione dei confini fra la Somalia e l’Etiopia e, in pari data, un’altra per i confini tra la Dancalia eritrea e l’Etiopia. Naturalmente il notevole spostamento di frontiera ebbe un prezzo: tre milioni di lire che entravano nelle casse dell’imperatore africano. Questi nel 1909 concesse al Colli uno degli appezzamenti più belli della città per la costruzione della nuova legazione italiana, che fu portata a termine nel 1911. Per il Colli seguirono altri anni di febbrile attività diplomatica, sempre corredati dal successo personale, sia ad Addis Abeba sia a Stoccolma, sia a Buenos Ayres e ancora ad Addis Abeba (1925) quando era già stato collocato a riposo. Il conte Colli morì a Rapallo il 12 settembre 1937, dopo anni di malattia, e riposa a San Michele di Pagana in un piccolo cimitero in riva al mare tra la caratteristica e vivace vegetazione ligure. Bibliografia: Giuseppe Colli di Felizzano, Nei paesi Galla a sud dello Scioa, in Bollettino della Società Geografica Italiana, Roma, Stabilimento Civelli, n° 1, gennaio 1905, pp. 8-18, n° 2, febbraio 1905, pp. 100-118, n° 4, aprile 1905, grande carta geografica a colori fuori testo del viaggio disegnata da Achille Dardano; Giuliano Cora, Giuseppe Colli di Felizzano, in Rivista di studi politici internazionali, Firenze, Editore Sansoni, n° 4, 1943, pp. 417-450; Monty Brown, Where Giants Trod. The saga of Kenya’s desert lake, London, Quiller Press, 1989, pp. 293-301; Ferdinando Martini, Il diario eritreo, quattro volumi, Firenze, Vallecchi Editore, 1942-1943; Giuseppe Vedovato, Gli accordi italo-etiopici dell’agosto 1928, Firenze, Biblioteca della “Rivista di studi politici internazionali”, 1956. |
 Bollettino dellla Società Geografica Italiana dove apparve la prima puntata della relazione di G. Colli di Felizzan |
 Bollettino della Società Geografica Italiana dove apparve la seconda parte della relazione di G. Colli di Felizzano |
 Particolare della carta geografica di Achille Dardano disegnata in base alle indicazioni del Conte Colli di Felizzano |
 Bollettino della S. G. I. con allegata la carta geografica disegnata da A. Dardano con l’esplorazione di Colli di Felizzano |
 La R. Legazione d’Italia ad Addis Abeba dove viveva Colli di Felizzano |
 Addis Abeba. La carrozza della R. Legazione d’Italia usata da Colli di Felizzano |
| index |