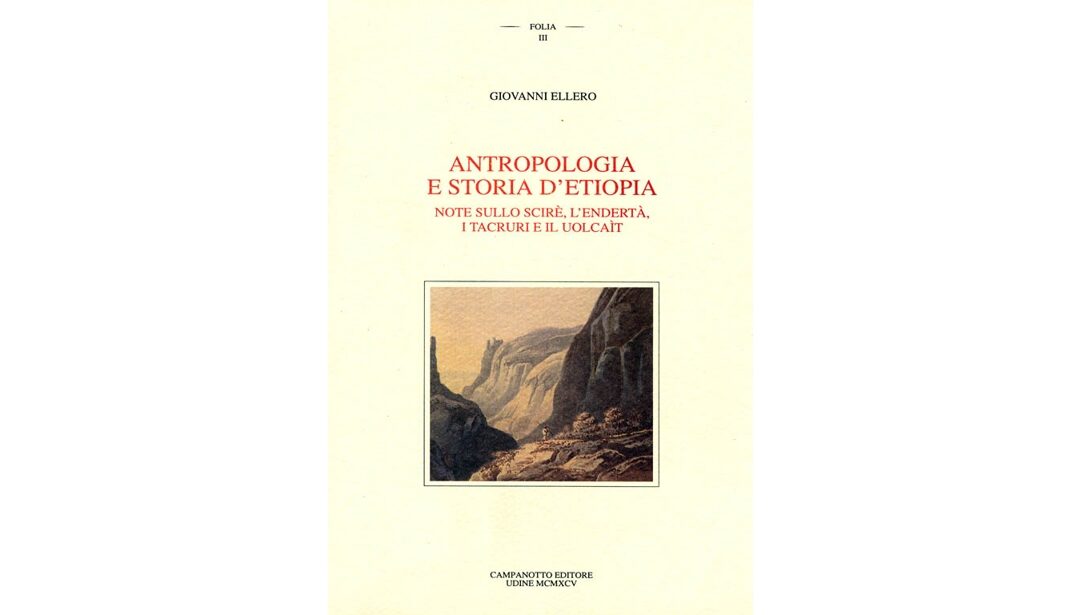Antropologia e storia d’Etiopia, Giovanni Ellero, Udine, Campanotto, 1995 – p. 146; 2. edizione 1999 ; € 14,46

Giovanni Ellero, nato a Tricesimo (Udine) il 17 luglio 1910, fu, nella sua breve vita, notevole figura di intellettuale e studioso, soprattutto della storia e cultura d’Etiopia. Plurilaureato (tra il 1931 e il 1935 ottenne le lauree in Giurisprudenza, in Scienze politiche e sindacali, e in Filosofia), dal maggio 1936 entrò in carriera presso il Ministero dell’Africa italiana e fu in servizio in diverse Residenze del Governo d’Etiopia. Dopo il febbraio 1941 venne internato a Decamerè. Morì il 28 novembre 1942, nel naufragio del piroscafo “Nova Scotia”, col quale centinaia di prigionieri e di internati civili italiani venivano allontanati dalle nostre ex-colonie.
Di lui resta un ricco Fondo presso la Biblioteca del Dipartimento di Discipline Storiche dell’Università di Bologna, con appunti e quaderni autografi di ricerche storico-antropologico-linguistiche, e un carteggio ala Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna con i messaggi che riusciva a trasmettere alla moglie Pia Maria Pezzoli, che lo aveva seguito in colonia, dal campo internati di Decamerè.[i]
“Antropologia e storia d’Etiopia” raccoglie gli unici suoi articoli pubblicati. I primi quattro comparvero tra il 1939 e il 1941 sul Bollettino della R. Società Geografica Italiana, sull’Archivio per la raccolta e lo studio delle tradizioni popolari italiane e sulla Rassegna di Studi Etiopici; gli ultimi due comparvero sulla “Rassegna di Studi Etiopici” tra il 1947 e il 1948 a cura di Carlo Conti Rossini, da cui, nei suoi anni di studio, Ellero aveva appreso il metodo di indagine antropologica.
Il testo presenta una prefazione di Gianfranco Fiaccadori, che illustra la situazione degli studi di etnologia etiopica ai tempi della formazione culturale di Ellero, con ricca bibliografia; segue l’introduzione di Gianfrancesco Lusini , che ha curato la raccolta[ii].
I sei saggi riguardano in particolare l’ Etiopia settentrionale, con particolare attenzione ai conventi ed al monachesimo. Conoscitore sia dell’amarico che del tigrino, Ellero è in grado di riportare tradizioni, leggende, curiosità delle zone del Tigrai, a cui si accosta con vero interesse e con rigore scientifico. In “I conventi dello Scirè e le loro leggende” si presenta l’importanza storica e sociale del monachesimo etiopico, presentando uno per uno i ventidue conventi dello Scirè, distretto per distretto.
“Una regione etiopica: lo Scirè” è una descrizione geografica, meteorologica, storica, floro-faunistica, demografica della zona, di cui si approfondiscono anche gli aspetti religiosi, le strutture sociali ed etiche, e le possibilità di valorizzazione.
Il breve, ma interessantissimo, “Importanza della tradizione orale per l’etiopistica” sottolinea come, in una società come quella abissina, che vive nel culto dei proverbi, nel diritto basato sulla memoria degli anziani, nella religiosità come insieme di consuetudini, occorra porre l’attenzione sulle fonti orali. Le fonti scritte, a questo punto, sono per l’etnologia meno importanti del paziente studio dedicato dallo studioso al vagliare dati, rettificare cronologie e personaggi, “rendersi ragione del perché l’attenzione popolare abbia insistito su un fatto particolare, trascurandone invece altri”.
Seguono “Note sull’Endertà” che confermano l’interesse di Ellero per le leggende e le tradizioni orali, approfondisce lo stato dei vari conventi, antico e contemporaneo.
“I Tacruri in Eritrea” esamina i componenti di una popolazione proveniente da varie parti dell’ Africa occidentale (Nigeria, Africa equatoriale francese, Darfur) che, recandosi alla Mecca e facendone ritorno, lasciava nuclei di famiglie, più o meno stabili; se ne analizzano denominazione, caratteristiche, vari nuclei, loro villaggi e rispettive origini, con anche uno schema comparato di un vocabolario dei sette gruppi “Tacruri”.
La raccolta si conclude con “Il Uolcaìt”, che riprende lo schema di presentazione già evidenziato per lo Scirè, con forse una maggiore rilevanza alle leggende e tradizioni.
Il testo, editorialmente curato in maniera apprezzabile, è corredato, oltre che da numerose foto, da una serie di cartine specifiche relative agli argomenti trattati.
———————————————
[i] Entrambi, donazioni di Stefano Pezzoli. Su Giovanni Elero e sul carteggio clandestino con la moglie Pia Maria Pezzoli, v. Gianni Dore, Scritture di colonia: lettere di Pia Maria Pezzoli dall’Africa orientale a Bologna (1936-1943), Bologna, Pàtron, 2004 e Valeria Isacchini, L’onda gridava forte: il caso del Nova Scotia e di altro fuoco amico su civili italiani, Mursia, 2008
[ii] Un’annotazione: a differenza di quanto riferisce Lusini, il Nova Scotia non venne colpito da unità della marina giapponese, ma dal sommergibile tedesco U-177. Lusini evidentemente si rifà a quanto scritto da Carlo Conti Rossini in una nota all’ultimo saggio. In effetti, all’epoca l’Eritrean Daily News, ex Quotidiano Eritreo, aveva addebitatoin in primo tempo ai giapponesi l’affondamento del Nova Scotia (v. V. Isacchini, cit., p. 209)
Index
© Il Corno d’Africa Tutti i diritti letterari e fotografici riservati