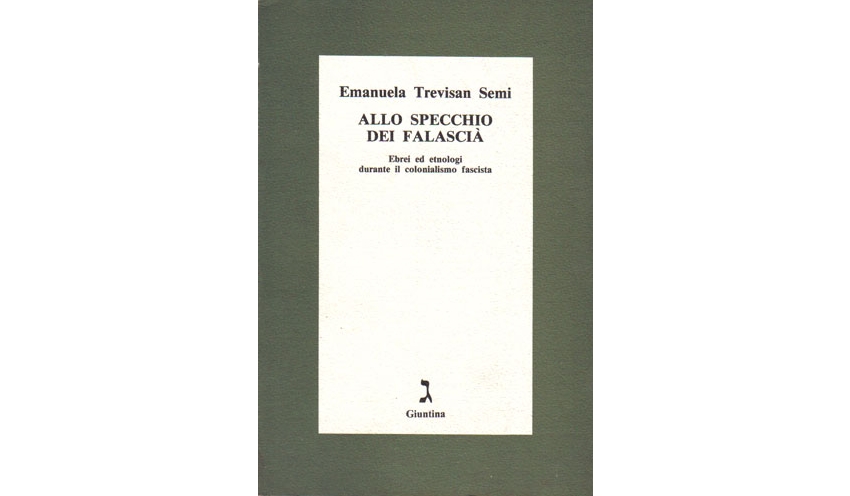| Emanuela Trevisan Semi ALLO SPECCHIO DEI FALASCIÀ: ebrei ed etnologi durante il colonialismo fascista – Firenze, Giuntina, 1987 Di Falascià si è ricominciato a parlare in Italia all’epoca dell’Operazione Mosè del 1985, tesa a portare in Israele gli ebrei d’Etiopia, e poi, più recentemente, in seguito al successo del film “Vai e vivrai” di Radu Mihăileanu. L’Autrice, all’epoca ricercatrice – attualmente professore associato – presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa settentrionale dell’Università di Venezia, ha avuto la possibilità di assistere alle difficoltà dell’integrazione dei Falascià in Israele, e questo l’ha spinta ad indagare sugli studi precedenti riguardanti questo gruppo. Una particolare sollecitazione agli studi sui Falascià (termine da loro rifiutato, a favore dell’espressione “Ebrei d’Etiopia”) si è verificata negli anni Trenta del secolo scorso, periodo particolarmente delicato per quanto riguarda gli studi antropologici. La Trevisan correttamente annota come sia più facile affrontare questi argomenti negli anni ’80 che negli anni ’30 (e quindi a maggior ragione sono apprezzabili quegli studi che all’epoca hanno utilizzato un metodo rispettoso e non invasivo); la sua tesi è che le difficoltà di studio su un gruppo disperso in villaggi, con dati vaghi su origine, emigrazione, spostamenti hanno fatto sì che gli studiosi che nel tempo hanno indagato gli ebrei d’Etiopia abbiano riflettuto nelle relazioni da loro pubblicate parte della propria immagine culturale (come direi che sempre succede, del resto). Il testo si può suddividere in quattro fondamentali punti di analisi: 1 – I Falascià e gli studi sulle loro origini (con un’analisi dei testi di Luzzatto, di Faïtlovich, di Conti Rossini ecc.) che hanno avanzato man mano ipotesi più o meno accreditate, ma non verificabili con sicurezza 2 – I rapporti tra ebrei italiani e Falascià: ai primi del ‘900 nacque il Comitato ebraico Pro-Falascià, per confermarne l’appartenenza israelitica e sottrarli agli sforzi di conversione da parte dei missionari evangelici. Si analizzano le polemiche che ne seguirono (l’ebraismo etiopico differisce per tradizioni e ritualità dall’ebraismo tradizionale, per cui questo intervento poteva essere visto comunque come un’intromissione nella cultura falascià), polemiche interrotte dalla Prima guerra mondiale e poi dalle diverse problematiche che si svilupparono nel campo ebraico in Europa (col diffondersi del sionismo in contrapposizione all’ antisemitismo). In Italia, sarà dopo la conquista dell’Etiopia che riprenderà l’interesse per i Falascià ( e gli studi dell’epoca vengono poi analizzati in diversa parte) 3 – Il razzismo in Italia : l’ A. distingue tra il razzismo come fenomeno effettivamente assai diffuso nella società europea, ovviamente Italia compresa, e l’esistenza di una politica razzista, che fa cioè del razzismo un’affermazione positiva. Il fascismo affrontò la questione ebraica, afferma l’A., con un atteggiamento duttile e diplomatico, che fece dell’antisemitismo un cinico uso più che uno scopo. Norme razziali (contro i pentecostali, contro gli abitanti dell’AOI) erano già precedenti le leggi del 1938, mentre nei confronti della questione ebraica Mussolini mantenne un atteggiamento alterno e possibilista che finì con il confondere gli stessi ebrei (che spesso erano convinti sostenitori del fascismo). E’ noto il progetto, concretamente studiato, di un insediamento ebraico in AOI (allontanandoli dalla Palestina e favorendo così il mondo islamico, che Mussolini, “spada dell’Islam”, appoggiava). Le stesse leggi del ’38 negavano la possibilità ad ebrei stranieri di trasferirsi nel Regno, in Libia e nell’Egeo, ma non si fa cenno alle colonie africane. 4 – Le missioni italiane in Etiopia : dopo la conquista dell’Etiopia, vennero notevolmente sviluppati gli studi di islamistica, etnografia, orientalistica, ecc.; si manifestarono aperte simpatie verso i Falascià, che erano stimati nel numero di 50.000. l’ A. procede ad uno studio delle relazioni delle numerose missioni etongrafiche che vennero condotte negli anni immediatamente seguenti, da parte di studiosi prevalentemente italiani, ma anche stranieri; l’ A. manifesta aperta stima per Conti Rossini, nonostante la sua indubbia adesione al fascismo, mentre mette in luce i discutibili sistemi adottati da Griaule. A questo punto, però, a mio parere, l’effetto specchio che l’A. riscontra negli studiosi (il riflettersi cioè della propria personalità e convincimenti negli studi condotti sui Falascià) si manifesta nella stessa Trevisan Semi. A pag. 101, ad esempio, a proposito della spedizione Dainelli sul lago Tana nel 1937 (da cui uscì una ponderosa relazione in 4 volumi), così afferma: ” L’interesse agli usi e costumi di questa popolazione veniva filtrato attraverso l’ideologia dominante di tipo razzista, basata soprattutto su pregiudizi antisemiti che impedivano di osservare obiettivamente i Falascià e di approfittare di tale esperienza sul campo. Se pensiamo che solo dieci anni più tardi W. Leslau […] otterrà una quantità di dati etnologici da permettergli di pubblicare l’opera fino ad oggi più completa della cultura dei Falascià, non ci resta che riflettere sull’ arretratezza della cultura, non solo etnologica, italiana”. Quel “solo dieci anni più tardi” è un’evidenziazione mia: se la tesi di fondo dell’A. è indubitabilmente vera, d’altra parte non è facile mettere a confronto un testo uscito nel 1937 con uno uscito nel 1947. Di mezzo c’era stato un decennio che aveva sconvolto e trasformato società e cultura. Così come quando, a proposito della missione di Carlo Alberto Viterbo nel 1936-37, afferma (pag. 113) che l’acquisto di tre manoscritti che portò con sè a Roma dimostra “interesse per gli aspetti scientifici del viaggio”, mentre poche pagine prima (p. 95) tali acquisti da parte di altri vengono considerati “azioni depredatorie”. La Trevisan è infatti convinta estimatrice ed ammiratrice della spedizione Viterbo, che fu favorito anche dall’essere correligionario dei Falascià, che quindi potevano accoglierlo senza timore di contaminarsi (più volte nel testo vengono riferiti i rituali per eliminare l’impuro dalla vita quotidiana, dai contatti con stranieri, ecc.). Viterbo si accosta infatti allo studio con un metodo “contemporaneo”, cioè con rispetto, curiosità, discrezione e manifestando il timore di distruzione culturale del mondo falascià. |