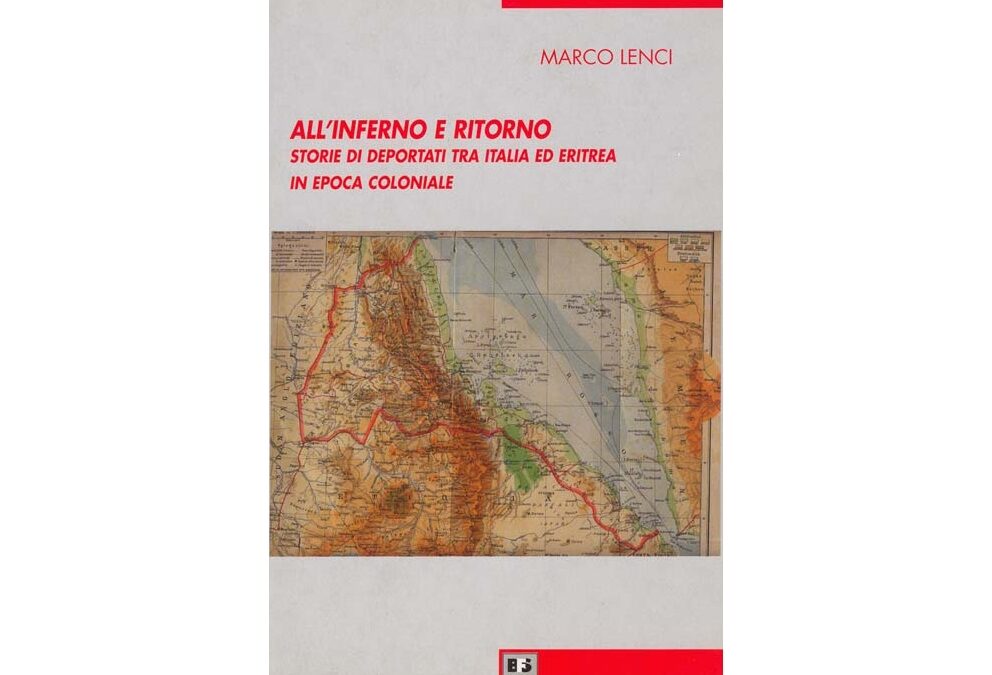| Marco Lenci, All’inferno e ritorno: storie di deportati tra Italia ed Eritrea in epoca coloniale, BFS edizioni, Pisa, ISBN 8886389957 143 p., 21 cm. € 13 Marco Lenci, docente di Storia dell’Africa presso l’Università di Pisa, ha approfondito in questo testo un aspetto poco noto e pochissimo studiato della storia dei rapporti tra Italia e colonie: quello delle deportazioni, o del domicilio coatto. Il volume si divide in tre parti. Nella prima viene analizzato il fenomeno delle deportazioni di Eritrei in Italia tra il 1886 e il 1893, fenomeno che interessò sia colpevoli di reati comuni sia ascari disertori, sia accusati di reati politici. I detenuti comuni vennero talvolta spostati in Italia a causa del sovraffollamento delle carceri eritree, e ricevevano un trattamento diverso rispetto ai civili inviati al confino per motivi politici; in questo secondo caso, del resto, la stessa magistratura italiana si rendeva conto dell’improponibilità giuridica del domicilio coatto, pena basata non su una condanna, ma su un sospetto. Pare evidente dal libro come la sorte dei prigionieri fosse seguita con la doverosa attenzione da parte delle autorità italiane, sia in occasione del rimpatrio dei civili inviati al domicilio coatto a Nisida (rimpatrio dovuto anche alle pressioni di Ras Makonnen in occasione del suo arrivo in Italia nel 1889 in vista della firma del trattato di Uccialli); sia in occasione della revisione dei documenti processuali riferiti allo “scandalo Livraghi”, quando si arrivò alla revisione del processo, alla restituzione dell’onore ai tre eritrei in un primo tempo condannati, e alla carcerazione dell’accusatore. Dopo il 1893 non venne più operato alcun trasferimento a scopo detentivo di eritrei in Italia. La seconda parte illustra la figura di un condannato politico in epoca fascista, Menghistu Isahac Tewolde Medhin (1911- 1995). Nato da una famiglia di intellettuali, di formazione protestante (aveva studiato presso i missionari svedesi), nel 1928 venne a Roma dove ottenne il diploma di Liceo scientifico per poi iscriversi al corso per ingegneri dell’Università di Roma. Le sue conclamate simpatie filoetiopiche gli procurarono, nel 1936, la condanna al confino, che scontò prima ad Ustica, poi alle Tremiti, infine a Ventotene, venendo a contatto con parecchi confinati “illustri” (tra i quali Sandro Pertini). Riuscì a rientrare in Eritrea solo nel 1945 e seguì poi una carriera dirigenziale, pur con diverse difficoltà a causa del suo carattere. La terza ed ultima parte ( a mio parere la più interessante) introduce il tema dello studio dell’utilizzo dell’Eritrea a scopi penitenziari. Anzi, l’argomento venne indagato dal Parlamento del Regno d’Italia prima ancora della conquista di una colonia (si ipotizzò la costruzione di “colonie penali” in località improbabili, quali le Aleutine, la Papuasia, il Borneo, le Nicobare….) Vengono ampiamente illustrate le difficoltà che immediatamente si riscontrarono per l’utilizzo di Assab come sede penitenziaria, difficoltà che però si ritenne di dover superare quando, dopo la repressione dei Fasci Siciliani, il numero di soggetti alla pena del domicilio coatto aumentò vertiginosamente, tanto che si rese necessario cercare nuovi spazi. Nel giugno 1898 vennero dunque inviati nella nuovissima colonia, nonostante i dubbi espressi dal governatore Martini e dal direttore della colonia penale, Caputo, 196 coatti; ma le difficoltà climatiche e l’inadeguatezza della sistemazione crearono immediatamente seri problemi, a cui si aggiunse già da settembre una gravissima emergenza sanitaria, che coinvolse sia i detenuti sia il personale di sorveglianza. Fu necessario un rimpatrio, prima graduale, poi generale; il disastroso esperimento ebbe fine nel febbraio 1899. Sotto il fascismo non si attuò alcuna deportazione coatta da e in Eritrea; il fenomeno rimase quindi, curiosamente, esclusivo dell’Italia liberale. Il volume è completato da un’ appendice che riporta testimonianze di familiari di Menghistu Isahac. |