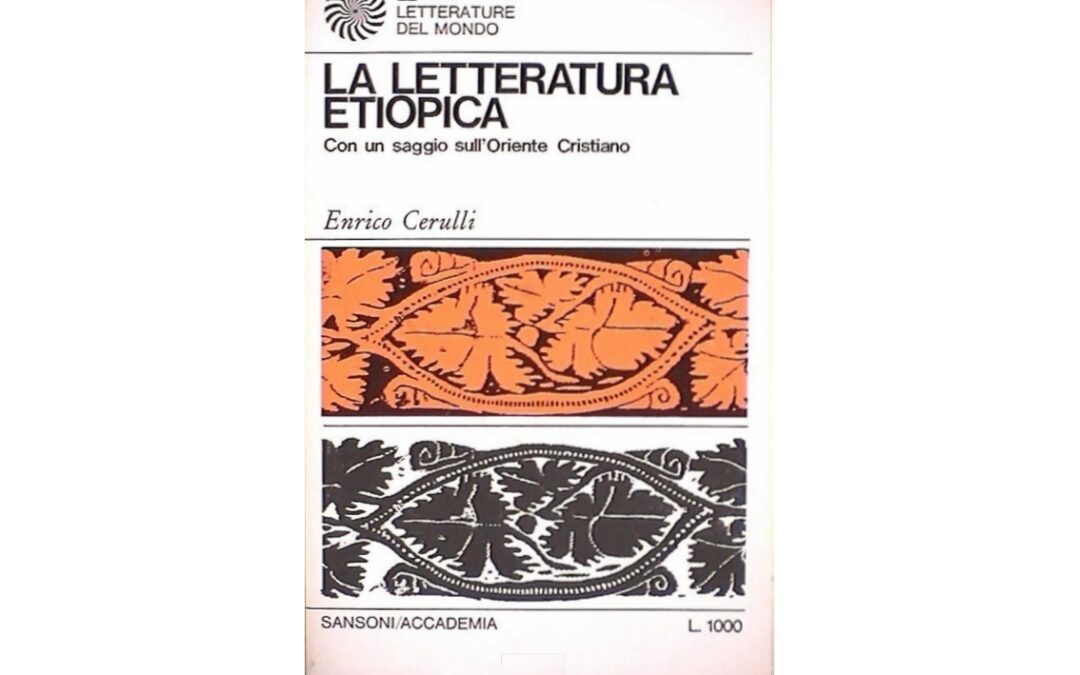edizioni Sansoni 1968
reperibile nelle librerie che trattano i “remainders” o in biblioteca
Leggi “Omaggio a Enrico Cerulli” https://www.ilcornodafrica.it/wp-admin/post.php?post=3311&action=edit
Il libro che vi consiglio questa volta può essere affrontato a due livelli.
Se avete una notevole cultura letteraria, potrete confrontare i testi etiopici con quelli europei degli stessi periodi, collegare letteratura e storia, approfondire basandovi sulle note e farvi sorprendere da un autore che, per spiegare bene un passaggio, va al British Museum, si fa consegnare un “codice” inedito e traduce direttamente dal Gheez (la lingua antica degli etiopi).
Noi persone normali, però, non dobbiamo scoraggiarci: non si tratta di un mattone illeggibile o per il quale sia necessaria una cultura pazzesca. Le cose che occorrono sono: amore per l’Etiopia in tutti i suoi aspetti, una conoscenza anche solo superficiale della storia di quel Paese, una matita per segnare i passaggi da rileggere con calma.
Uno dei fili conduttori del libro è la storia etiopica, come la conosciamo dalle guide turistiche. Se abbiamo presente a grandi linee la leggenda di Salomone e della regina di Saba, la storia di Axum e della conversione al cristianesimo del re Ezana, di Lalibelà e delle chiese rupestri, dei re di Gondar, del riunificatore Teodoro, di Giovanni IV e Menelik II, possiamo ritrovare gli stessi soggetti, ma questa volta in originale.
Per esempio, è del 1300 il famosissimo Chebra Neghèst (La Goria dei R) che è il libro in cui si trova il racconto di Salomone e della Regina di Saba, del loro figlio Menelik e dell’Arca dell’Alleanza portata da questi in Etiopia e tuttora conservata, secondo la leggenda, in una cappella della chiesa di Mariam Tsion ad Axum. E’ affascinante poter leggere direttamente dalla fonte una storia che è stata banalizzata dalle guide turistiche ma che invece presenta inaspettati risvolti poetici.
Del periodo di Axum possiamo confrontare due iscrizioni del re Ezana, prima e dopo la conversione: è divertente come, quasi senza farsi notare, nella seconda opera egli sostituisca il nome e gli appellativi del dio Mahrem, al quale credeva prima di convertirsi, con il Dio unico dei cristiani, definendo già da allora la prudenza come tratto fondamentale della letteratura etiopica.
Le solite guide turistiche ci hanno già informato delle api che si posarono su Lalibelà bambino o dei sogni che portarono il re a far costruire con l’aiuto degli angeli le famose chiese nella roccia, ma qui possiamo sapere senza intermediari come egli scelse la moglie per ordine divino o come la affidasse all’angelo Michele per andare in pellegrinaggio a Gerusalemme.
Dei re di Gondar il più citato dalle guide è Fasiladès (quello della piscina vicino ai castelli merlati) che troviamo negli Atti della santa Wolatta Petros, una figura femminile coraggiosa e fiera che non esita nel prender decisioni a difesa della fede anche senza consultare il re.
Il 19°e poi il 20° secolo vedono l’affermarsi delle lingue amarica e tigrina al posto dell’antico etiopico in opere storiche che ci parlano dei grandi imperatori precedenti ad Hailè Selassiè: fra tutti, è bello, sia per la tensione emotiva che trasmette, sia per la curiosità storica, il racconto della morte del tigrino Giovanni IV che preferisce morire sul campo di battaglia contro un nemico esterno piuttosto che essere battuto dal suo antagonista interno, il futuro Menelik II.
La lettura del libro ci porta anche ad ampliare le nostre conoscenze storiche con le cronache delle guerre condotte, circa nel 1300, da Amda Tsion, uno dei primi re dopo che Yekuno Amlak ebbe ripristinato la dinastia dei Salomonidi, presentato dai suoi contemporanei come leale e coraggioso. A solo cento anni di distanza, però, durante l’era del re Zara Yacob, il valoroso Amda Tsion viene mostrato come un re peccatore e indegno, persecutore di cinque santi monaci con i quali si accendono continui dissidi ed a cui sono dedicate ampie biografie.
Nel capitolo ottavo, dedicato alle invasioni che l’Etiopia subì nel 1500, troviamo la storia dell’invasione dei Galla, fieri e sanguinari, e una lucida, desolata e a tratti comica riflessione sulla superiorità bellica degli invasori, che si dedicano tutti alla guerra, mentre gli etiopici si dividono in dieci classi di cui nove rifiutano categoricamente di combattere con le più diverse motivazioni.
Con l’invasione musulmana, la letteratura etiopica si arricchisce di Storie scritte da ambedue le parti, cristiana e islamica: è quindi interessante osservare lo stesso periodo da punti di vista opposti, anche perché la lettura è agevole, ricca di particolari e in certi punti divertente.
Un’altra possibile chiave di lettura sono le opere religiose. Un posto particolare hanno le numerose opere riferite alla Madonna, fra cui spicca per importanza il Libro Etiopico dei Miracoli di Maria, che ha un’origine francese ma si è via via arricchito di contributi europei e medio orientali, in una specie di viaggio letterario nella fantasia che termina in Etiopia circa nel 1400. I racconti ufficialmente riconosciuti dalla chiesa etiopica sono 33, ma fortunatamente, a causa dell’indipendenza di cui godevano i singoli monasteri, ne sono arrivati a noi molti altri.
Ancora, notevoli sono gli Atti dei fondatori dei maggiori monasteri, fra cui la parte più divertente si trova negli Atti di Giovanni l’Orientale, verso la fine del quarto capitolo, in cui facoceri, iene e istrici si alleano con il drago contro San Giovanni che infine li sconfigge in maniera singolare.
Curiosa, alla fine del sesto capitolo, è la lettera dell’abate Nicodemo al Papa Eugenio IV in occasione di una missione etiopica al Concilio di Firenze: il povero abate deve contemporaneamente ribadire l’autorità del re Zara Yacob e non dispiacere al Papa, difendere la dottrina monofisita e mantenere buoni rapporti con gli occidentali.
Ci sono anche opere religiose scritte al tempo dell’invasione musulmana, da entrambe le parti, allo scopo di mostrare la superiorità della propria religione e difenderla da defezioni spesso dettate dalla convenienza. Bizzarra (e già sbagliata di parecchi secoli) la profezia del monaco Enbakom che predice alla religione musulmana 1000 anni di esistenza (e soltanto grazie ai peccati dei cristiani, perché altrimenti sarebbero stati solo 700).
Anche gli eretici danno il loro contributo, magari mascherandosi da difensori della religione ufficiale, ed il “Viaggio alla ricerca della conoscenza di Dio” dei Micaeliti, nel capitolo decimo, è un capolavoro di ambiguità per come cerca di far passare l’eresia fra le pieghe del monofisismo etiopico, ma a noi interessa di più la forma del racconto che assomiglia alle tipiche fiabe africane e lo rende bellissimo.
Concludendo, è un testo non facilissimo da leggere, ma presenta due innegabili vantaggi: uno, che Cerulli spiega bene anche i passaggi più impegnativi; due, che al contrario di un romanzo si possono saltare le parti difficili (particolarmente faticose le poesie con lo stile “Cera e oro” nel 10° capitolo) e magari tornarci alla fine del libro.
Vi assicuro che sarà una lettura affascinante. Del resto, accanto alle opere di tradizione europea, perché non offrire ai nostri figli opere etiopiche, come quelle già citate o come il racconto della Madonna e del cane assetato del quinto capitolo? Senza contare le poesie, tra le quali vi segnalo: quella dedicata alla Crocifissione nel terzo capitolo, la poesia guerresca, scarna ma vigorosa, contro un mancato usurpatore del trono che si trova alla fine del capitolo settimo, e le “Effigi” del capitolo dieci che fanno le lodi di ciascuna parte del corpo del Santo che si vuole celebrare, partendo dalla testa fino ai piedi…
Non perdetelo!